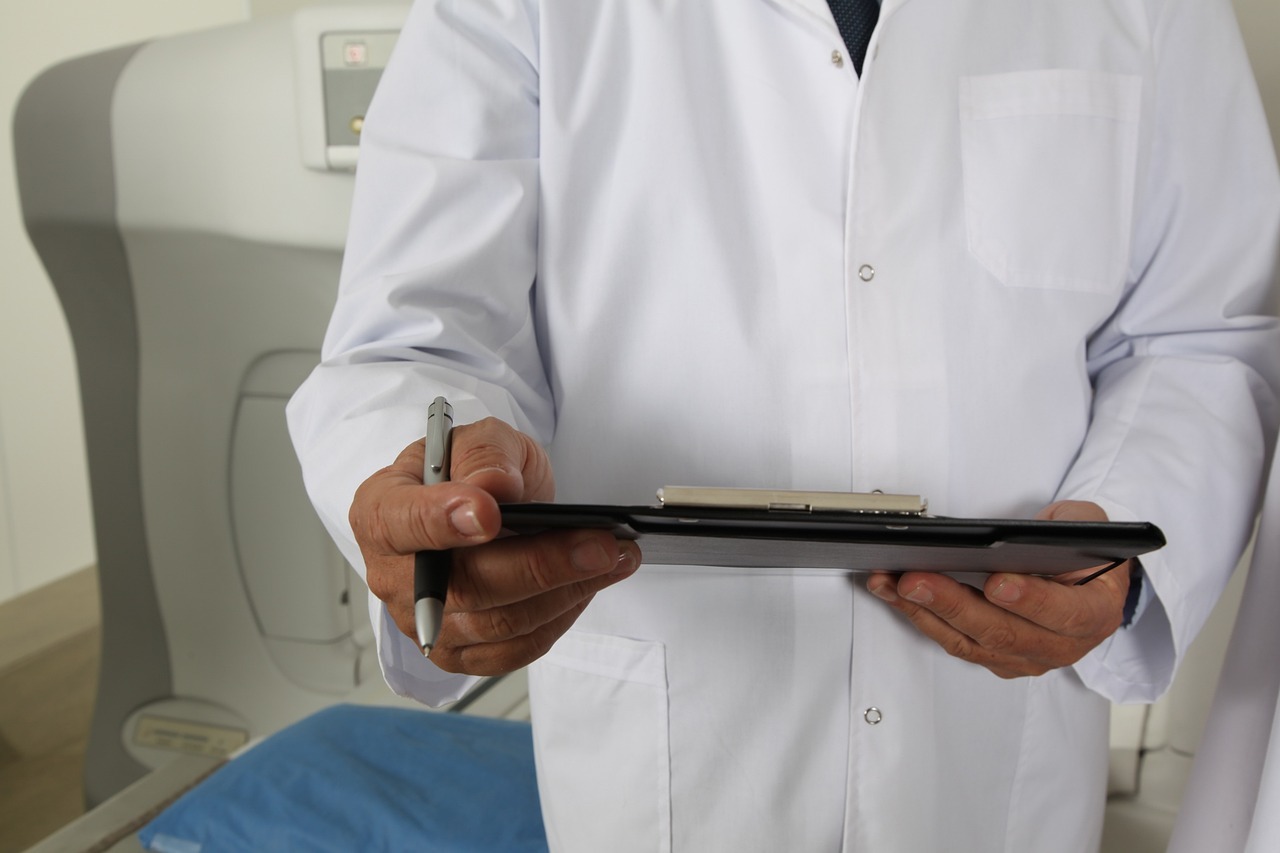Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla Malattia di Huntington, una patologia genetica rara che, pur essendo nota da tempo, resta ancora poco conosciuta al grande pubblico. Dal 15 maggio, molte associazioni internazionali promuovono la Giornata mondiale dedicata a questa malattia, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e rompere il silenzio che spesso la circonda.
Già descritta in epoca medievale, la prima definizione clinica moderna risale al 1872, quando il medico americano George Huntington pubblicò un articolo in cui identificava la trasmissione ereditaria e le caratteristiche principali del disturbo. Successivamente, la malattia è stata oggetto di studi approfonditi in Europa e negli Stati Uniti, specialmente durante la riscoperta delle leggi mendeliane
Ne ha parlato il prof. Ferdinando Squitieri in un articolo su Quotidiano Sanità, utilizzato per questo testo come una delle fonti.
Una patologia ereditaria e neurodegenerativa
Indice dei contenuti
La malattia di Huntington è un disturbo genetico raro e progressivo che colpisce il sistema nervoso centrale. Di natura neurodegenerativa, questa condizione compromette progressivamente la coordinazione motoria, le capacità cognitive e la salute mentale. I sintomi solitamente iniziano nella mezza età, tra i 35 e i 45 anni, e includono movimenti involontari (noti come corea), cambiamenti dell’umore e difficoltà cognitive.
Trasmessa con una probabilità del 50% da un genitore affetto a ciascun figlio, la causa è una mutazione genetica ben identificata. Diagnosticabile anche prima della comparsa dei sintomi grazie a un test sul DNA disponibile dagli anni ’80. Purtroppo, non esiste ancora una cura definitiva. La malattia è progressiva, coinvolge il sistema nervoso centrale e compromette progressivamente il corpo e la mente. Chi ne è colpito sviluppa difficoltà motorie, movimenti involontari evidenti e comportamenti alterati. Questi ultimi possono includere aggressività, depressione, perdita di iniziativa e disturbi del sonno.
Huntington: l’ansia dell’attesa e le sfide della diagnosi precoce
L’attesa della malattia, nei soggetti a rischio, può trasformarsi in un costante stato d’ansia, come se si vivesse con una “bomba genetica” pronta a esplodere. Due aspetti rendono l’Huntington particolarmente drammatica. Il primo è il fattore tempo, con intere generazioni coinvolte nell’assistenza dei propri cari. Il secondo l’imprevedibilità della manifestazione, soprattutto nelle fasi iniziali, quando i segnali possono essere confusi con altri disturbi psichiatrici. Questo rende ancora più difficile una diagnosi precoce.
La conoscenza è ancora limitata
Secondo dati di Eurordis, nel 2012 il 23% dei professionisti tendeva a ignorarla. Anche l’accesso a un’assistenza adeguata è molto variabile. Le carenze sono sia nell’ambito del supporto psicologico che nella prescrizione di farmaci specifici, come evidenziato da ricerche condotte dalla Fondazione LIRH. La mutazione che causa l’Huntington colpisce prevalentemente una zona del cervello chiamata striato, ma può manifestarsi anche in età infantile o giovanile, in forme ancora più rare e aggressive. Di solito però insorge in età adulta, colpendo persone nel pieno della propria vita personale e lavorativa. Non fa distinzioni sociali e rappresenta un pesante onere economico e psicologico per le famiglie coinvolte.
Segni in combinazione
Secondo l’Huntington Society of America, i sintomi combinano aspetti della Malattia di Parkinson, della SLA e dell’Alzheimer.
Variano da persona a persona ma seguono un’evoluzione prevedibile. Le prime manifestazioni possono essere lievi problemi comportamentali o cognitivi, seguiti da difficoltà motorie. Con il tempo, la malattia compromette seriamente l’autonomia del paziente, rendendo necessaria un’assistenza costante. La durata media dalla comparsa dei sintomi alla morte è di circa 20 anni, con complicanze comuni come infezioni polmonari o problemi cardiaci.
Huntington: approfondiamo i sintomi
Disturbi motori
I primi segnali fisici della malattia sono spesso movimenti involontari e scoordinati chiamati corea, che si manifestano come agitazione, piccoli spasmi e difficoltà nei movimenti oculari rapidi. Questi disturbi motori lievi possono precedere di anni l’insorgenza di sintomi più gravi, come rigidità muscolare, posture insolite e movimenti contorti, che indicano un coinvolgimento delle aree cerebrali responsabili del controllo motorio.
Con la progressione della malattia, le funzioni psicomotorie si riducono sensibilmente: diventano difficoltose azioni quotidiane come camminare, parlare, masticare o deglutire. Questa compromissione può causare perdita di peso e malnutrizione, oltre a disturbi del sonno. Nei bambini e adolescenti affetti, la malattia tende ad avanzare più rapidamente e la rigidità si presenta come sintomo principale fin dalle prime fasi, spesso accompagnata da crisi epilettiche.
Alterazioni cognitive
Dal punto di vista cognitivo, il deterioramento è progressivo e coinvolge soprattutto le funzioni esecutive, ovvero quelle che consentono di pianificare, adattarsi ai cambiamenti, prendere decisioni e controllare i propri comportamenti. Con il tempo, si manifestano problemi di memoria, sia a breve che a lungo termine, inclusa la perdita della memoria autobiografica e delle abilità pratiche. Questo deterioramento può evolvere in una forma di demenza definita “sottocorticale”, che si distingue da quella tipica dell’Alzheimer.
Problemi psichiatrici e comportamentali
I disturbi psichiatrici sono comuni e comprendono irritabilità, apatia, ansia, depressione e, in alcuni casi, comportamenti ossessivi o psicotici. I pazienti possono mostrare una ridotta risposta emotiva, atteggiamenti egocentrici e tendenze aggressive o compulsive, con il rischio di sviluppare dipendenze come l’alcolismo o la dipendenza da gioco. Sono frequenti anche difficoltà nel riconoscere le emozioni altrui.
La presenza di questi sintomi, che variano ampiamente da individuo a individuo, può compromettere gravemente la qualità della vita e rappresenta una delle principali cause di stress per le famiglie. Pensieri suicidari sono più comuni nei pazienti affetti rispetto alla popolazione generale.
Huntington: coinvolgimento totale
Sebbene la malattia sia principalmente neurologica, la proteina huntingtina mutata è attiva in tutto l’organismo, causando problemi anche a livello sistemico. Tra le conseguenze più comuni si segnalano atrofia muscolare, disfunzioni cardiache, perdita di massa ossea, problemi metabolici e riduzione della funzione testicolare.
Mutazioni spontanee
In Italia si stimano circa 6.000 persone affette e 30.000 a rischio genetico, cifre destinate ad aumentare, non solo per il progressivo invecchiamento della popolazione, ma anche per il potenziale emergere di nuove mutazioni spontanee. È quindi essenziale rafforzare la conoscenza pubblica e medica di questa patologia. L’Huntington potrebbe infatti rappresentare, insieme ad altre condizioni neurodegenerative, una crescente sfida sociale e sanitaria, anche in considerazione delle previsioni dell’OMS, che stimano 150 milioni di persone con demenza entro il 2050.
Guardare al futuro con speranza
Oggi esistono terapie farmacologiche utili a gestire i sintomi comportamentali e mentali. Soprattutto, la ricerca scientifica sta compiendo progressi significativi: sono in corso oltre 60 studi clinici in Nord America e circa 40 in Europa, alcuni dei quali puntano a intervenire sul RNA o a modificare l’espressione genica attraverso terapie innovative. In particolare, proprio in maggio 2025, una sperimentazione su un farmaco che agisce sullo splicing dell’RNA ha raggiunto risultati promettenti, aprendo la strada a nuove prospettive terapeutiche.