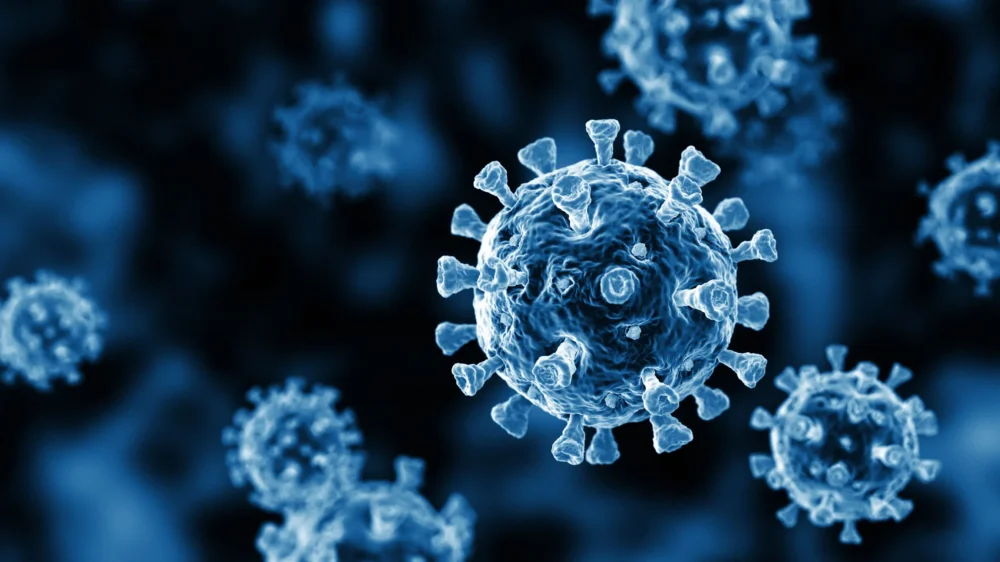Covid e cervello: durante i lunghi mesi del lockdown, molti hanno avuto la netta sensazione che il tempo scorresse in modo anomalo. Le giornate sembravano dilatarsi, le settimane diventavano mesi. Ma questa non era solo una percezione emotiva. Secondo uno studio dell’Università di Nottingham, pubblicato su Nature Communications, la pandemia da Covid-19 ha davvero lasciato un segno profondo nei nostri cervelli.
I ricercatori hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per stimare l’età cerebrale di oltre 15.000 persone sane, con un’età media di 62 anni. Il risultato è sorprendente: dopo la pandemia, i cervelli apparivano invecchiati di circa cinque mesi e mezzo rispetto all’età cronologica. Un logoramento non causato dal virus in sé, ma dallo stress collettivo vissuto durante quel periodo.
Covid e cervello: l’invecchiamento cerebrale accelerato
Indice dei contenuti
I cambiamenti osservati dai ricercatori non sono invisibili. La riduzione dello spessore della corteccia cerebrale e il calo del volume della materia grigia sono segnali tipici dell’invecchiamento neurologico. In tempi normali, questi processi si sviluppano lentamente. Ma la pandemia ha accelerato il declino in modo anomalo.
La causa non risiede solo nel lockdown o nella solitudine. A pesare sono stati anche l’incertezza economica, la paura del contagio, il lutto, il crollo della routine quotidiana. Tutti elementi che, sommati, hanno generato una condizione di stress cronico capace di alterare la struttura del cervello.
Lo stress prolungato, infatti, attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, generando un flusso continuo di cortisolo. Questo ormone, in dosi elevate e costanti, ha un impatto negativo sulle funzioni cognitive e può favorire la degenerazione neuronale.
Covid e cervello: differenze di genere, età e contesto sociale
L’invecchiamento cerebrale non ha colpito tutti allo stesso modo. Le persone più vulnerabili, come gli uomini in condizioni sociali precarie, hanno riportato i danni maggiori. Anche chi non ha contratto il virus ha subito gli effetti psicologici della pandemia, a dimostrazione che l’impatto è stato collettivo e trasversale.
Uno studio parallelo, condotto dall’Università di Washington su adolescenti americani, ha evidenziato un altro dato allarmante. I cervelli dei ragazzi sottoposti a scansione dopo la pandemia erano più vecchi di quanto previsto per la loro età. In media, l’invecchiamento appariva maggiore nelle ragazze, con un’anticipazione di oltre quattro anni, contro un anno e mezzo nei ragazzi.
La spiegazione? Le ragazze adolescenti, secondo i ricercatori, sono più dipendenti dall’interazione sociale per il loro equilibrio emotivo e lo sviluppo cerebrale. L’isolamento ha interrotto questa rete di supporto invisibile, lasciando un vuoto che ha inciso sulla salute mentale e neurologica.
Resilienza: perché reagiamo in modo diverso alle stesse condizioni
Non tutti però hanno reagito allo stesso modo. Alcune persone sono uscite dalla pandemia più forti, altre più fragili. Questa differenza si spiega con un concetto chiave: la resilienza.
La resilienza non è solo forza mentale. È la capacità dell’organismo, e del cervello in particolare, di adattarsi agli eventi traumatici, metabolizzare lo stress e trovare nuovi equilibri.
Fattori genetici, ambientali, esperienze pregresse, livello di istruzione, relazioni familiari, accesso a cure e supporti psicologici: tutto questo contribuisce a determinare il livello di resilienza di una persona.
In generale, le persone con maggiore resilienza sono in grado di riorganizzare le reti neurali, attivando meccanismi di compensazione. Questo significa che, anche in condizioni di stress, riescono a preservare le funzioni cognitive e a contenere l’invecchiamento cerebrale.
Chi è meno resiliente, al contrario, tende ad accumulare stress in modo passivo, andando incontro più facilmente a disturbi dell’umore, decadimento cognitivo, insonnia o burnout.
Covid e cervello: le cicatrici neurologiche
Oltre all’invecchiamento cerebrale indotto dallo stress, il Covid ha lasciato segni tangibili in chi ha contratto il virus in forma grave. Alcune ricerche condotte nel Regno Unito hanno rivelato che, a distanza di un anno dal ricovero, il cervello di queste persone appariva invecchiato anche di vent’anni.
Non si tratta solo di perdita di memoria o difficoltà di concentrazione. I danni osservati includono riduzione delle connessioni sinaptiche, alterazioni nella microstruttura della materia bianca e rallentamenti nelle risposte cognitive.
Questo tipo di declino è simile a quello osservato in malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Non è detto che questi effetti siano permanenti, ma richiedono sicuramente un lungo processo di recupero e monitoraggio.
Tabella esplicativa: invecchiamento cerebrale e fattori di rischio
| Fattore | Effetto sul cervello | Intensità del danno | Reversibilità |
|---|---|---|---|
| Stress cronico | Aumento cortisolo, perdita sinaptica | Moderata | Parzialmente reversibile con supporto psicologico |
| Isolamento sociale | Declino cognitivo, depressione | Elevata nei soggetti fragili | Variabile |
| Covid grave | Danno strutturale, riduzione materia grigia | Molto alta | Da valutare caso per caso |
| Condizioni socioeconomiche precarie | Maggior vulnerabilità neurologica | Elevata | Legata a fattori ambientali |
| Alta resilienza | Maggiore protezione cerebrale | Bassa incidenza di danni | Può contrastare l’invecchiamento |
Una speranza possibile: il cervello si può rigenerare
Non tutte le conseguenze della pandemia sono definitive. Il cervello ha una straordinaria capacità di adattamento, chiamata neuroplasticità. Significa che, in presenza degli stimoli giusti, può ricostruire connessioni, creare nuovi circuiti e riprendere alcune funzioni compromesse.
Per sostenere questo processo, è fondamentale puntare su attività che favoriscano la salute cerebrale: esercizio fisico regolare, socializzazione, alimentazione equilibrata, sonno di qualità e stimolazione cognitiva.
Anche l’aiuto psicologico può rivelarsi decisivo. La terapia, individuale o di gruppo, aiuta a rielaborare lo stress, ridurre l’ansia e ricostruire un senso di controllo sul proprio percorso.
Un bilancio ancora aperto
La pandemia ha rappresentato un evento di rottura. Ha messo a nudo le fragilità individuali e collettive. Ci ha costretti a fare i conti con l’imprevedibilità, l’isolamento, la paura e la perdita.
Ma ha anche aperto nuove strade per comprendere meglio il funzionamento del nostro cervello. Le ricerche avviate in questi anni ci stanno restituendo una visione più chiara e completa della salute mentale e neurologica.
I segni lasciati dal Covid non sono sempre visibili, ma sono reali. Non servono solo nuove cure, ma anche nuove politiche sociali, educative e sanitarie capaci di supportare la ricostruzione emotiva e cognitiva delle persone.
Perché, come ricordano i ricercatori di Nottingham, non tutto è perduto. Molti danni non sono irreversibili. Serve solo tempo, comprensione e un rinnovato impegno per prenderci cura di ciò che abbiamo dentro: anche quando non si vede.