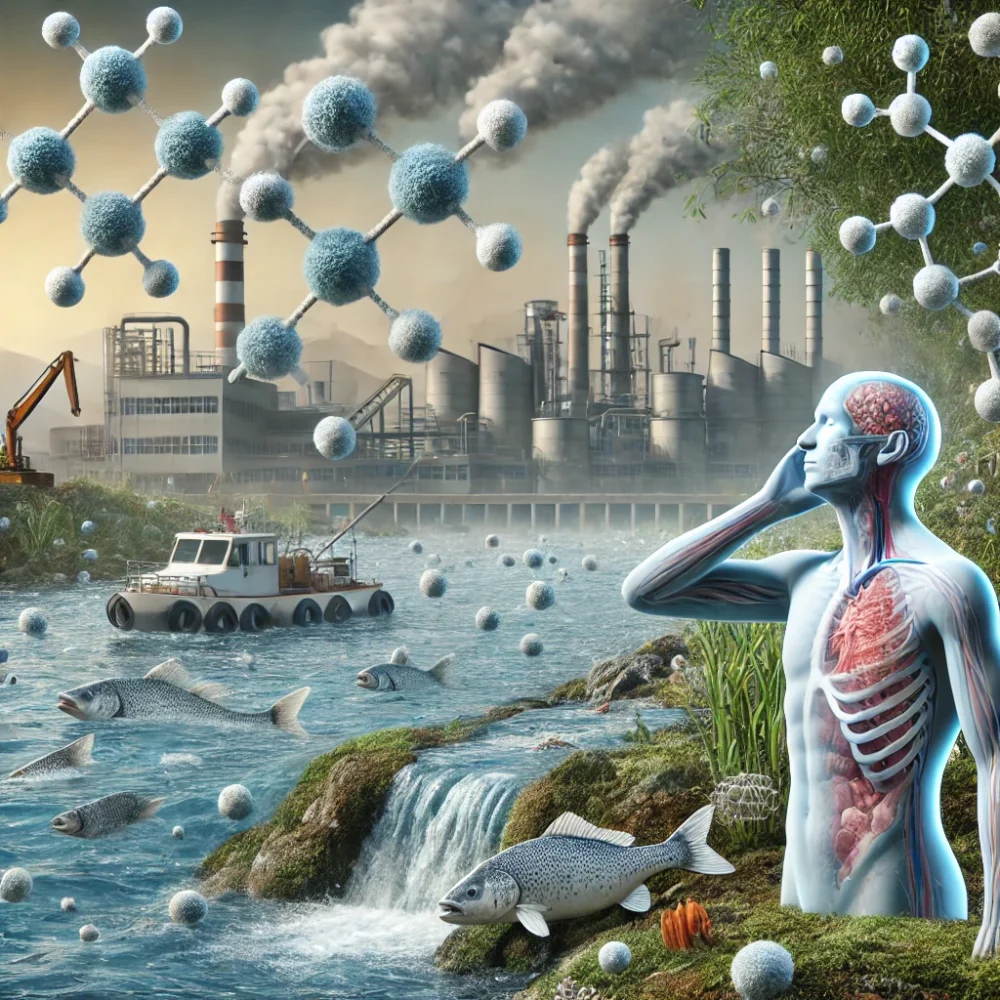Le sostanze alchiliche per e polifluorurate (PFAS), conosciute come “chimiche per sempre”, rappresentano una minaccia persistente per l’ambiente e la salute umana. Ora, uno studio ha individuato undici geni che potrebbero svelare il meccanismo della loro neurotossicità
PFAS: un problema globale tra ambiente e salute
Indice dei contenuti
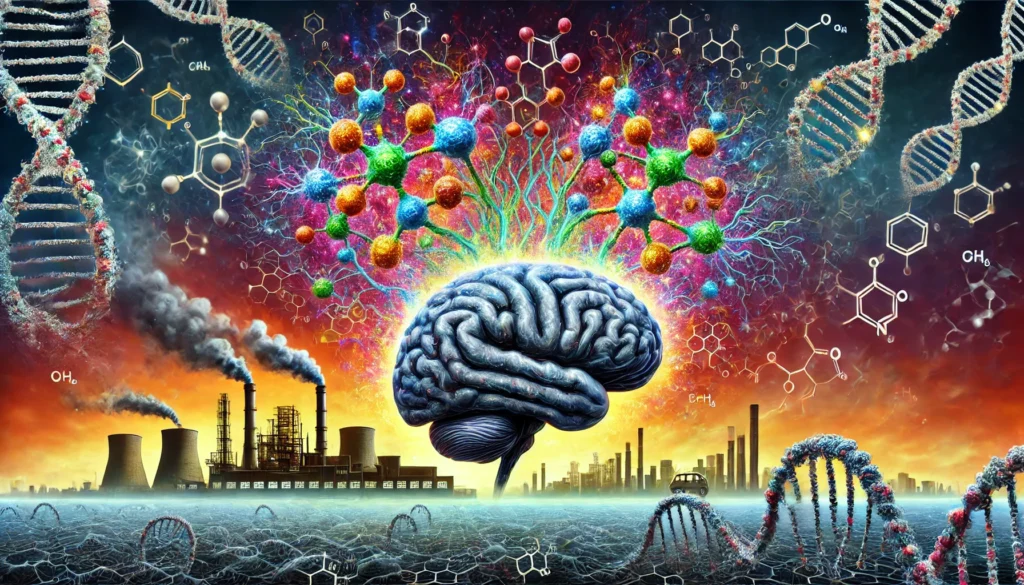
Le sostanze PFAS sono ovunque. Utilizzate per decenni in applicazioni come pentole antiaderenti, tessuti impermeabili e schiume antincendio, queste molecole resistono alla degradazione e si accumulano nell’ambiente, nell’acqua potabile e persino nei tessuti umani. La loro capacità di attraversare la barriera emato-encefalica e raggiungere il cervello li rende particolarmente insidiosi, ma i meccanismi precisi attraverso cui danneggiano le cellule neuronali erano fino ad ora poco compresi.
Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Buffalo ha aperto una finestra su questo complesso problema, rivelando come i PFAS influenzino l’espressione genica e il metabolismo cellulare. Pubblicato sulla rivista ACS Chemical Neuroscience, questo lavoro ha identificato i cambiamenti molecolari che si verificano nelle cellule nervose esposte a questi composti, offrendo una visione chiara degli effetti neurotossici a lungo termine.
Lo studio: decodificare la neurotossicità dei PFAS
L’esperimento si è concentrato su sei tipi di PFAS comunemente presenti nell’ambiente, inclusi composti ormai noti come il PFOA (acido perfluoroottanoico), precedentemente utilizzato nelle padelle antiaderenti e considerato altamente pericoloso dall’EPA. I ricercatori hanno esposto cellule neuronali differenziate a questi composti, monitorando l’espressione genica e i cambiamenti lipidici.
L’obiettivo era duplice.
Identificare i geni influenzati dai PFAS e capire come questi composti alterano i lipidi, elementi fondamentali per la struttura e la funzione delle membrane cellulari. Dopo 24 ore di esposizione, i risultati hanno mostrato variazioni significative nell’espressione di oltre 700 geni e nei lipidi associati alle cellule nervose. Di particolare rilievo è stato il PFOA, che ha dimostrato di essere il più tossico tra i composti testati, influenzando quasi 600 geni.
Undici geni sotto la lente: marcatori della neurotossicità
Tra le centinaia di geni analizzati, undici hanno mostrato risposte uniformi a tutti i PFAS testati, indipendentemente dal loro tipo o struttura. Due di questi geni si sono rivelati particolarmente significativi:
1. Il fattore neurotrofico mesencefalico derivato dagli astrociti (MANF): essenziale per la sopravvivenza delle cellule neuronali, ha mostrato una riduzione costante dell’espressione. Questa alterazione potrebbe compromettere la capacità del cervello di proteggere i neuroni, aumentando il rischio di malattie neurodegenerative;
2. La proteina che interagisce con la tioredossina (TXNIP): responsabile dell’attivazione di processi che portano alla morte cellulare, ha mostrato un aumento dell’espressione, indicando un potenziale rischio di neurodegenerazione indotta dai PFAS.
I pericoli nascosti nei dettagli molecolari
Lo studio ha dimostrato che i PFAS non agiscono in modo uniforme. Ogni composto, pur condividendo alcune caratteristiche chimiche, presenta variazioni nella struttura molecolare che determinano effetti distinti sulle cellule. Ad esempio, mentre il PFOA ha mostrato un impatto significativo sull’espressione genica, altri PFAS hanno provocato alterazioni più moderate, pur influenzando vie biologiche cruciali come lo stress ossidativo e il metabolismo degli aminoacidi.
Questo dimostra che i PFAS non possono essere trattati come una classe unica di sostanze, ma devono essere studiati individualmente per comprendere appieno i loro effetti biologici e trovare soluzioni mirate.
Un futuro tra prevenzione e ricerca
Nonostante i rischi associati ai PFAS, eliminarli completamente dall’uso quotidiano rimane una sfida. Questi composti sono indispensabili in applicazioni come la produzione di semiconduttori e le schiume antincendio, dove le loro proprietà uniche sono difficilmente sostituibili. Tuttavia, gli scienziati stanno esplorando alternative come i PFAS a catena corta, che sembrano persistere meno nell’ambiente e accumularsi meno nei tessuti biologici.
Questa transizione, però, non è priva di incognite. La minore persistenza ambientale potrebbe comportare una riduzione dell’efficacia in alcune applicazioni, e gli effetti sulla salute dei sostituti richiedono ulteriori indagini. La ricerca attuale, guidata dal team dell’Università di Buffalo, rappresenta un passo fondamentale per identificare i PFAS più dannosi e sviluppare strategie per ridurre il loro impatto.
Fonti
Logan Running et al., ACS Chemical Neuroscience, 2024. DOI: 10.1021/acschemneuro.4c00652
Meredith Forrest Kulwicki, Università di Buffalo.