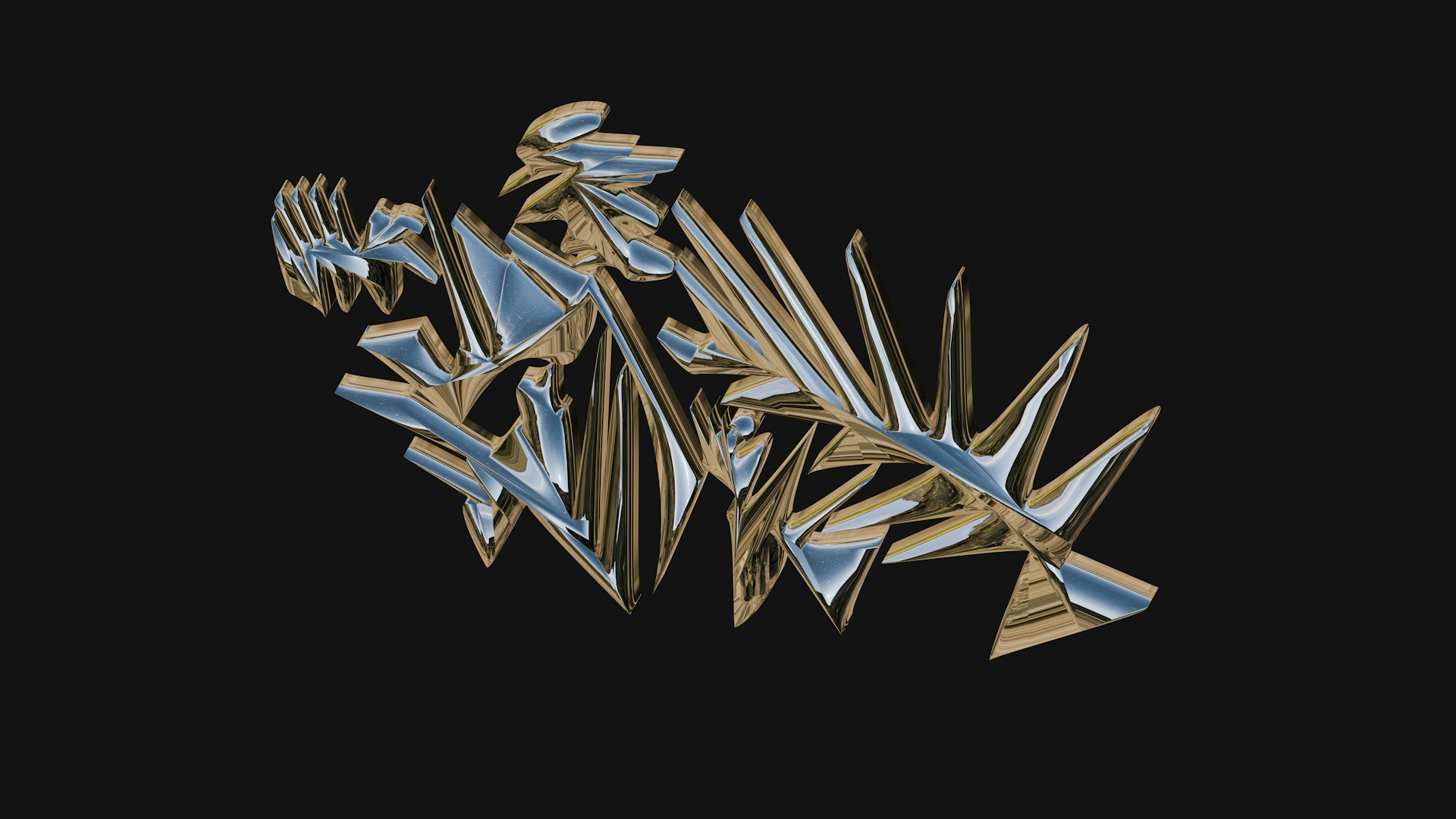
In questa guida parliamo di cromo, un metallo molto usato e foriero di problemi alla salute, specialmente nei lavoratori esposti. Vediamo quali sono le categorie di lavoratori esposti al cromo, quali sono le vie d’esposizione e i danni alla salute. Vediamo anche come si articolano prevenzione e sicurezza e quali sono i diritti dei lavoratori esposti.
Il cromo: che cos’è?
Indice dei contenuti
Ma andiamo con ordine: che cos’è il cromo? Il cromo è un elemento chimico appartenente alla famiglia dei metalli di transizione. Si presenta in natura come un metallo grigio lucente, duro e fragile.
Il suo nome deriva dal greco chroma, che significa “colore”, perché i suoi composti possono assumere tonalità molto vivaci, come il verde, il giallo e il rosso. Esistono diversi stati di ossidazione del cromo, ma i più comuni sono il cromo trivalente (Cr III) e il cromo esavalente (Cr VI). È proprio quest’ultimo a destare le maggiori preoccupazioni dal punto di vista della salute, per via della sua elevata tossicità e della sua classificazione come sostanza cancerogena.
Dove si trova il cromo e quali sono i suoi impieghi
In natura, il cromo si trova principalmente sotto forma di minerali, in particolare nella cromite, da cui viene estratto industrialmente. La sua presenza è diffusa in alcune rocce e suoli, ma può anche essere rilasciato nell’ambiente attraverso le attività umane, specialmente quelle industriali.
Dal punto di vista industriale, il cromo è molto apprezzato per la sua capacità di resistere all’ossidazione e alla corrosione. Per questo motivo viene largamente utilizzato per la produzione di acciai inossidabili, leghe metalliche e rivestimenti protettivi. È frequente trovarlo nei processi di cromatura, che conferiscono lucentezza e durezza a oggetti metallici come rubinetti, utensili, parti di automobili e biciclette. Il cromo è impiegato anche nella produzione di pigmenti, vernici, conciatura delle pelli, materiali refrattari, prodotti chimici e conservanti per il legno. Alcuni composti vengono usati anche nell’industria della ceramica e dei fertilizzanti.
Impieghi delle diverse forme di cromo
Il Cromo III è considerato un oligoelemento essenziale nella dieta umana, poiché necessario in piccole quantità per favorire il metabolismo del glucosio e agire in sinergia con l’insulina per regolare la glicemia e potenziarne l’azione nei tessuti.
Le principali fonti di Cromo VI provengono da attività industriali, come la produzione e la lavorazione dell’acciaio nell’industria metallurgica e galvanica, la concia delle pelli, la produzione tessile e la fabbricazione di prodotti a base di cromo. Anche la combustione di gas naturale, petrolio o carbone può rilasciare cromo nell’ambiente. Di solito non rimane nell’atmosfera, ma si deposita nel terreno e nell’acqua, e può cambiare forma a seconda delle condizioni presenti.
Il Cromo VI è ampiamente utilizzato nell’industria per rivestimenti protettivi e decorativi e nella preparazione di diverse leghe. Viene anche impiegato come preservante del legno, mordente e fissativo nell’industria tessile, nella produzione di farmaci per uso umano e veterinario e come colorante nei cosmetici.
I rischi per la salute: quando il cromo diventa pericoloso
Sebbene il cromo trivalente (Cr III) sia un oligoelemento necessario in piccolissime quantità per il metabolismo umano, il cromo esavalente (Cr VI) è estremamente pericoloso. I composti di cromo VI sono irritanti, sensibilizzanti e, in molti casi, cancerogeni. L’inalazione di polveri o fumi contenenti cromo VI può causare gravi danni all’apparato respiratorio. Tra le reazioni più comuni si riscontrano infiammazioni delle mucose nasali, ulcere del setto nasale, bronchiti croniche e, nei casi più gravi, tumori polmonari.
Il contatto con la pelle può provocare dermatiti irritative e allergiche, mentre l’ingestione accidentale può condurre a disturbi gastrointestinali, danni al fegato e ai reni. L’esposizione cronica, anche a basse dosi, è quindi estremamente rischiosa per la salute umana. Il cromo VI può penetrare attraverso la pelle lesa o i polmoni e raggiungere altri organi, accumulandosi nel tempo.
Normativa vigente: limiti consentiti nelle acque
Il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato un Decreto Ministeriale datato 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della Salute insieme al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Questo provvedimento, entrato in vigore il 15 luglio 2017 e riguardante le acque destinate al consumo umano, stabilisce un nuovo limite precauzionale per il Cromo VI pari a 10 microgrammi per litro (µg/L).
Questo nuovo valore limite per il Cromo VI si aggiunge a quello già esistente per il Cromo, che è di 50 µg/L e comprende tutte le forme di Cr senza distinzioni (Direttiva 98/83/CE).
Normativa europea: contatto con alimenti
Il Cr è incluso nell’Allegato II del Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Questo Allegato elenca le sostanze soggette a limitazioni generali per il loro utilizzo in materiali plastici e oggetti a contatto con gli alimenti. Ogni sostanza elencata ha un limite specifico di migrazione che non deve essere superato. Nel caso del Cromo, questo limite è di 0,01 milligrammi per chilogrammo (mg/kg).
Quali sono i limiti per l’esposizione professionale?
Per i composti di Cromo VI, classificati come cancerogeni secondo la direttiva 2004/37/CE, è stato stabilito un valore limite di 0,005 milligrammi per metro cubo (mg/m3).
Le misure di gestione del rischio nell’Unione Europea previste dal Regolamento REACH (CE n 1907/2006) prevedeono che alcuni composti di Cromo VI (triossido di cr, dicromato di potassio e cromato di sodio) non possano più essere utilizzati nell’Unione Europea a partire dal 21 settembre 2017, a meno che non siano specificamente autorizzati. Stabiliscono inoltre restrizioni per articoli in cuoio e articoli con parti in cuoio che possono venire a contatto con la pelle dei consumatori o dei lavoratori e cemento.
Nel primo caso è stata adottata una restrizione per ridurre il rischio di sensibilizzazione della pelle causato dal contatto diretto o indiretto con articoli in cuoio o prodotti contenenti parti in cuoio con Cromo VI. Tale contatto può scatenare una risposta allergica in persone già sensibilizzate, anche a concentrazioni inferiori rispetto a quelle necessarie per sensibilizzarsi.
Stabilisce che tali articoli non possono essere messi sul mercato se contengono Cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 milligrammi per chilo (mg/kg – 0,0003% in peso) del peso totale a secco del cuoio.
Nel caso del cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o utilizzati se contengono, una volta miscelati con acqua, oltre lo 0,0002% di Cromo VI idrosolubile del peso totale a secco del cemento.
Le malattie professionali legate all’esposizione al cromo
L’INAIL riconosce tra le malattie professionali legate all’esposizione al cromo diverse patologie, in particolare quelle associate ai composti del cromo VI. Tra queste, le più gravi sono i tumori del polmone e dei seni paranasali, condizioni che si sviluppano dopo un’esposizione prolungata e documentata nel tempo.
Oltre alle forme tumorali, sono riconosciute anche affezioni non neoplastiche, come la rinite cronica, le ulcere del setto nasale, l’asma professionale, la dermatite allergica da contatto e alcune forme di congiuntivite. Queste patologie, pur non sempre gravi, possono compromettere significativamente la qualità della vita lavorativa e personale di chi ne è colpito.
Il riconoscimento della malattia professionale avviene attraverso una procedura che prevede la dimostrazione dell’esposizione lavorativa al cromo e la diagnosi clinica della malattia. I lavoratori colpiti hanno diritto a ricevere un risarcimento, sotto forma di indennizzo o rendita, a seconda della gravità della menomazione.
Le categorie di lavoratori più esposte
Le categorie professionali maggiormente a rischio includono gli operai impiegati nella cromatura elettrolitica, nella produzione e lavorazione dell’acciaio inossidabile, nei settori della siderurgia, della saldatura, della verniciatura industriale e della galvanotecnica. Anche chi lavora nella concia delle pelli, nella fabbricazione di pigmenti, nelle fonderie e nella manutenzione di impianti industriali può essere esposto a concentrazioni significative di cromo.
È importante sottolineare che il rischio non riguarda soltanto chi maneggia direttamente il metallo o i suoi composti, ma anche chi si trova nei pressi di lavorazioni che rilasciano polveri o fumi contenenti cromo VI. La contaminazione può avvenire anche attraverso abiti da lavoro non adeguatamente puliti o superfici non decontaminate.
Le vie d’esposizione al cromo
Le principali vie di esposizione al cromo sono l’inalazione, il contatto cutaneo e, in casi meno frequenti, l’ingestione. L’inalazione è di gran lunga la via più pericolosa, poiché le particelle di cromo VI possono penetrare in profondità nei polmoni e causare danni duraturi ai tessuti. Questo accade specialmente nei luoghi di lavoro con scarsa ventilazione, dove si effettuano operazioni come la saldatura, la fusione di metalli o la sabbiatura.
Il contatto cutaneo diretto con polveri o soluzioni contenenti cromo può scatenare reazioni allergiche o irritative, soprattutto se la pelle presenta lesioni. L’ingestione è rara nei contesti lavorativi, ma può avvenire in modo accidentale se non vengono rispettate le norme igieniche, ad esempio mangiando o fumando in ambienti contaminati.
Prevenzione e sicurezza: proteggere chi lavora con il cromo
La prevenzione è il cardine della tutela della salute nei confronti del rischio da esposizione al cromo. In primo luogo, è fondamentale una corretta valutazione del rischio da parte del datore di lavoro. Deve identificare tutte le attività potenzialmente pericolose, monitorare i livelli di esposizione e predisporre un piano di protezione adeguato.
È essenziale che gli ambienti di lavoro siano dotati di sistemi di ventilazione e aspirazione localizzata. Questi permettono di ridurre al minimo la presenza di polveri e fumi. Allo stesso tempo, i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale efficaci, come maschere con filtri specifici, guanti resistenti ai prodotti chimici e indumenti protettivi.
Un altro elemento chiave è la formazione continua del personale. I lavoratori devono essere informati sui rischi connessi all’uso del cromo e sulle misure da adottare per proteggersi. Devono inoltre essere incoraggiati a segnalare tempestivamente ogni sintomo sospetto e a rispettare scrupolosamente le norme di igiene sul lavoro, come lavarsi le mani prima di mangiare o evitare di portare indumenti contaminati a casa.
I diritti dei lavoratori esposti al cromo
Chi lavora a contatto con il cromo ha diritto a una sorveglianza sanitaria periodica, condotta dal medico competente dell’azienda. Questa attività ha lo scopo di individuare precocemente eventuali effetti negativi dell’esposizione, consentendo di intervenire tempestivamente.
Se un lavoratore sviluppa una patologia che può essere messa in relazione con l’attività lavorativa, ha diritto a presentare denuncia all’INAIL. In caso di riconoscimento della malattia professionale, potrà accedere alle prestazioni previste: risarcimento per danno biologico, rendite per inabilità permanente, indennità giornaliera per assenza dal lavoro e, nei casi più gravi, prestazioni assistenziali aggiuntive.
Anche in assenza di una diagnosi conclamata, il lavoratore ha diritto a chiedere il trasferimento ad altra mansione priva di rischio, se è stato accertato un rischio elevato per la salute. La legge italiana prevede che la sicurezza venga prima di tutto e che ogni persona debba lavorare in un ambiente sano e protetto.
Malattie profesisonali inserite nella lista I
- ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE I.1.05. J34.8
- DERMATITE ULCERATIVA I.1.05. L98.4
- DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO I.1.05. L23.0
- ASMA BRONCHIALE I.1.05. J45.0
Per il cromo esavalente:
- TUMORE DEL POLMONE I.1.05. C34
- TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI^ II.6.34.^ C30.0^
- TUMORE DEI SENI PARANASALI^ II.6.34.^ C31^
Per le malattie inserite nella lista I dell’INAIL vige la presunzione legale d’origine. Ciò significa che al lavoratore malato viene riconosciuta la malattia professionale (per ottenere rendita o indennizzi INAIL): gli basta dimostrare la presenza della lavorazione. Spetta al datore di lavoratore provare l’inesistenza del nesso causale. Per i lavoratori del settore publbico non privatizzato purtroppo non è così: devono dimostrare il nesso di causalità.

